di Andrea Muni
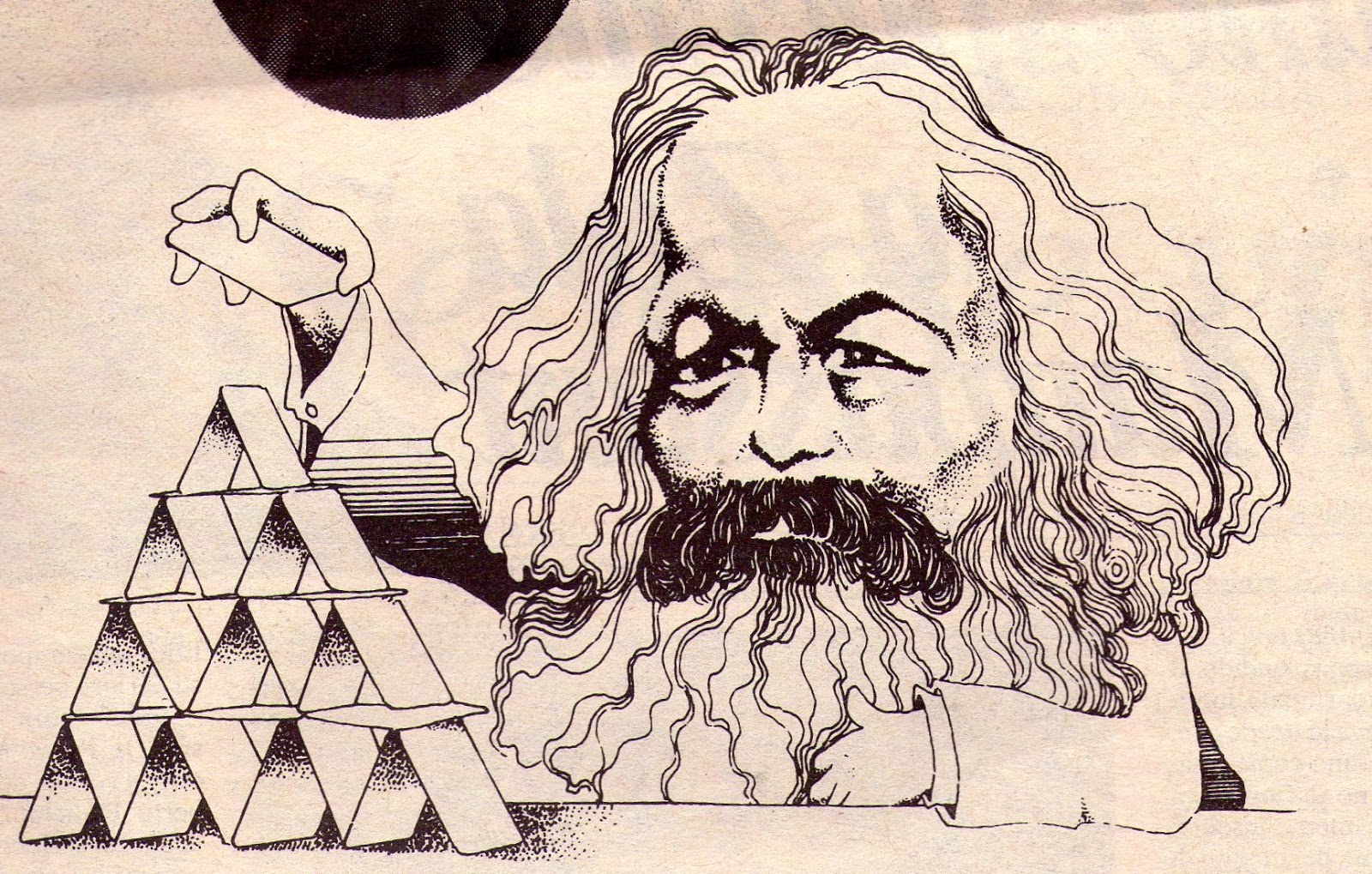 Muni: Ha ancora senso, secondo lei, occuparsi di Marx oggi? Crede sia possibile un nuovo e differente utilizzo pratico, e politico in senso lato, dei suoi scritti e delle sue teorie (magari capace di separarsi dalle due esperienze del “marxismo” che sono state dominanti lungo il secolo breve, vale a dire quella umanistica e quella scientifico-economicistica)?
Muni: Ha ancora senso, secondo lei, occuparsi di Marx oggi? Crede sia possibile un nuovo e differente utilizzo pratico, e politico in senso lato, dei suoi scritti e delle sue teorie (magari capace di separarsi dalle due esperienze del “marxismo” che sono state dominanti lungo il secolo breve, vale a dire quella umanistica e quella scientifico-economicistica)?
Ronchi: La risposta automatica, alla sua domanda retorica, è certamente sì. L’insegnamento di Marx è a mio avviso oggi più che mai attuale, e utile, per chiunque si proponga di manomettere i perversi meccanismi politici che stanno conducendo le nostre società neo-liberali verso un neanche troppo lento ed inarrestabile declino etico e sociale.
In un momento storico – qual è quello odierno – in cui il pensiero di Marx sembra a molti qualcosa di sorpassato, ritengo fondamentale rivalutare proprio un aspetto del suo pensiero che, forse, lei ha troppo rapidamente congedato come scientifico/economicistico. Nonostante sia innegabile che questa impostazione abbia condotto a vicoli ciechi politicamente tutt’altro che vincenti, credo infatti che ad essa vada reso il merito storico-culturale di aver riscoperto il profondo antiumanismo di Marx, sforzandosi in tal modo di sottrarre il suo pensiero all’ingombrante affiliazione moralistica, cristiana e progressista che non ha mai cessato di minacciarlo. Penso ad esempio ad Althusser, a come egli abbia a suo modo riesumato scientificamente la “crudeltà” del pensiero marxiano (lo dico nel senso artaudiano), rivalutandone la dimensione di “veggenza”. Una veggenza non tanto intesa come previsione del futuro, quanto piuttosto come capacità di penetrare il presente con occhio critico, capacità cioè di guardare – oltre e attraverso i muri della sovrastruttura – dritto in faccia agli ingranaggi attuali e reali della macchina capitalistica.
La crudezza e l’apparente freddezza di molte delle analisi di Marx rappresentano, paradossalmente, una risorsa politica importante da rimettere in gioco oggi. Il collasso prodottosi a sinistra durante gli ultimi vent’anni è stato infatti sostanzialmente il collasso di un pensiero storicista, progressista e umanista, un pensiero in fondo ancora cristiano nella sua aspirazione. Con la scomparsa (o la decimazione) irreversibile delle sinistre da buone parte dei parlamenti d’Europa, è scomparsa (o per lo meno è rimasta irrimediabilmente menomata) una concezione politica dell’Uomo che perdurava almeno dal secondo dopoguerra.
L’Uomo dell’umanismo post-bellico è ormai definitivamente saltato per aria, e con esso i molti dualismi che ne avevano nutrito il mito: natura/cultura, materia/spirito, soggetto/oggetto. Ripensare oggi costruttivamente a Marx significa, a mio avviso, considerarlo come il capostipite di una linea minoritaria del pensiero contemporaneo; una linea che si è sviluppata lungo l’ultimo secolo e mezzo della nostra storia, nella penombra dell’ingombrante retorica umanista.
Se da un lato infatti abbiamo la grande linea fenomenologico-esistenziale – che ha messo al centro del proprio pensiero politico la questione della finitezza e quella della tecnica, accomunando paradossalmente il marxismo umanista sartriano e il presunto antiumanismo di Heidegger – sull’altro versante possiamo invece individuare, a partire dal pensiero di Marx, un filone che ha avuto la tendenza a considerare il concetto di Uomo come una produzione meramente storico-politico-economica.
Negli scritti del cosiddetto giovane Marx riluce già, senza ambiguità, il tentativo di costruire e socializzare un al di là dell’Uomo. Marx ci dice, ad esempio nella Critica dell’ideologia tedesca, che l’Uomo è ciò che il mondo borghese chiama “uomo”. Le stesse Tesi su Feuerbach affermano chiaramente che parlare dell’Uomo significa parlare di un’astrazione. E allo stesso modo, nel Libro terzo del Capitale, Marx afferma senza mezzi termini – deformando quella che era già stata una sentenza hegeliana – che il sistema capitalistico dei bisogni, definiti non a caso “umani”, funziona come una sorta di seconda natura.
Muni: Per Marx dunque la cosiddetta seconda natura è – in un certo senso – il primo avversario politico da aggredire eticamente e individualmente. Sembrerebbe quasi che la lotta sia da condurre contro quella che avvertiamo come la nostra attuale (e naturale) natura umana. Anche perché in fondo – considerando proprio il suo antiumanismo – Marx non ha mai creduto all’esistenza di alcuna natura umana dietro alla seconda natura del capitalismo, così come non ha mai creduto che fosse possibile il ritorno ad un supposto uomo “originario” imprigionato dietro all’uomo prodotto dal capitale.
Ronchi: Sì, Marx aveva intuito brillantemente, già nei Grundrisse, che il sistema di accumulazione capitalista (denaro produce denaro) non è in alcun modo accomunabile a un processo naturale – come ritenevano invece ideologicamente gli economisti “classici”, in particolare anglo-sassoni. Nella sua analisi del processo di accumulazione capitalista Marx aveva intravisto che la produzione dei desideri umani è essenzialmente connessa all’idea di una macchina che funziona secondo un certo modello, un modello che non è affatto quello biologico-naturale delle “macchine umane”, bensì quello economico, e sociale, logicamente implicato proprio dal sistema di produzione capitalistico. Marx ha svelato che il capitale si nutre di se stesso, innestandosi nei soggetti come la regola apparentemente naturale di una razionale intenzionalità desiderante volta alla soddisfazione di bisogni.
Muni: Eppure, di contro, qualcuno potrebbe obiettare, forse giustamente, che sono pur sempre i soggetti a far funzionare la macchina capitalista, e aggiungere che se ciò accade, in un certo senso, siamo costretti ad ammettere che esiste una qualche perversa convenienza personale nell’accettare di giocare il gioco della rincorsa alla propria soddisfazione individuale secondo le regole del capitale. Noi non siamo solo vittime del capitalismo, ne siamo al contempo anche gli artefici.
Ronchi: Certo, qui tocchiamo l’essenza del problema posto da Marx quando ha articolato uno dei suoi concetti fondamentali, quello di materialismo storico. Viene prima l’azione umana libera e insensata attraverso cui l’uomo produce le strutture che lo determinano, o vengono prima le strutture economico-politiche che ne pre-determinano l’azione individuale, i bisogni e i desideri? Cosa è causa di cosa?
Questo è uno dei tanti paradossi marxiani, forse irrisolvibile, e chissà, forse solo apparente. Esso è stato ripreso in chiave originale e profonda anche da un pensatore ultra-umanistico come Jean Paul Sartre, nel suo libro certamente meno umanistico: La critica della ragione dialettica. Secondo Sartre, Marx afferma che il soggetto è soggetto in quanto è strutturalmente e inestricabilmente un ingranaggio della macchina, non il suo padrone. Questa affermazione si presta a una doppia lettura, che chiama in causa il delicato concetto di alienazione e l’ancor più delicato problema di una sua eventuale soluzione.
Prima lettura: l’uomo è alienato dal processo capitalista e bisogna liberarlo dalla macchina (lettura umanista, questione della tecnica, preteso ritorno alla naturalità perduta dell’uomo). Seconda lettura: l’ultra umanista Sartre ci dice, nel secondo tomo della Critica della ragione dialettica, che il contadino che lavora la terra può lavorare la terra perché, a suo modo, egli è già di per sé una “macchina”. Fuor di metafora, il senso di questo apologo sartriano è che, se siamo potuti diventare soggetti e operatori della macchina capitalistica, questo significa che – in qualche modo da sempre – noi siamo strutturalmente capaci di funzionare come tali. Ciò implica che, nella lotta contro l’alienzazione capitalista, non si tratterebbe tanto di rifiutare gli elementi macchinici e spersonalizzanti che intaccano il concetto umanistico di Uomo, quanto piuttosto di esercitarsi a giocarli a controsenso. A questo proposito nei Grundrisse Marx suggerisce implicitamente una via di uscita dal capitalismo proprio in questa direzione: non un ritorno al preteso Uomo naturale pre-macchinico deturpato dal capitale, ma piuttosto una sovversione del funzionamento, e del rapporto dell’uomo, con la macchina capitalistica stessa.
Muni: Quindi, a questo livello, più che un antiumanismo quello di Marx potrebbe essere considerato un contro-umanismo? Esso sembrerebbe porsi infatti come un’alternativa radicale alla contrapposizione dialettica umanismo-antiumanismo. Quali autori secondo lei hanno proseguito con maggior successo la via contro-umanistica aperta da Marx?
Ronchi: Il pensiero del Novecento, fino a tempi recentissimi e salvo rare eccezioni, ha sublimato con la parola Uomo l’idea mitica di un soggetto trascendentale. La tradizione minoritaria a cui facevo riferimento poco fa, quella che appunto possiamo far risalire fino a Marx, Nietzsche e Freud, è stata ereditata da autori quali Whitehead, Foucault, Deleuze, un certo Lacan e molti altri. Tutti questi autori, attraversando mille difficoltà e imboccando sicuramente parecchi vicoli ciechi, hanno cercato di mettere a tema un’esperienza di Uomo sganciata dal soggetto della coscienza. La coscienza, per tutti questi autori, non è che un sottoinsieme dell’esperienza umana, una sua piega. Questa linea di pensiero, quando tematizza l’esperienza, non la considera più nell’orizzonte della coscienza e del rapporto soggetto-oggetto. La più grande “bestemmia” del Novecento, in senso positivo, è stata proprio questa: l’affermazione di un’esperienza che non è di niente e di nessuno, acefala.
Muni: In questo solco si collocano quindi anche l’esperienza sovvertita del desiderio e la rielaborazione radicale dell’idea di bisogno che Marx opponeva alla “psicologia” dell’homo oeconomicus neo-liberale descritto da Foucault in Nascita della biopolitica. Può sembrare forse stupefacente, ma questa esperienza del desiderio (razionalizzante, progettuale e tutta centrata sul soggetto pensante) era già stata abbozzata (e denunciata) proprio da Marx, nella seconda parte dei Manoscritti economico-filosofici, come l’esperienza del desiderio peculiare al soggetto capitalista.
Ronchi: Si, in questa chiave non mi sembra azzardato vedere nella pagine del Secondo capitolo dei Manoscritti economico-filosofici un primo abbozzo critico di quella che Lacan elaborerà e definirà come la frattura tra desiderio e godimento. Per Lacan il godimento è l’evaporazione di quel soggetto intenzionalmente desiderante che coincide con la seconda natura capitalista. Il venir meno del riferimento privilegiato alla dimensione della coscienza, però, non ci riconsegna affatto alle calde braccia di un’irenica e nostalgica presunta naturalità dell’Uomo, ci sospinge invece in tutt’altra direzione.
Credo che esistano oggi due esperienze antagonistiche del godimento. Se da un lato, come aveva già mostrato Marx nei Manoscritti, la questione del godimento si articola nella forma di un godimento di beni effimeri, intenzionale e progettuale, in cui il soggetto soddisfa la propria singolarità narcisistica attraverso il consumo di merci superflue, dall’altro lato – quello che potremmo definire contro-umanista – il godimento sembrerebbe proprio non essere altro, paradossalmente, che l’esperienza acefala dell’evaporazione, o della perdita, dell’omologazione fondamentalmente politica del soggetto vivente al soggetto cosciente, intenzionale e progettuale che si soddisfa (e autoindividua) attraverso il consumo effimero di beni.
Marx nei Manoscritti aveva già mostrato, in maniera cristallina, e da fine psicologo, come nel godimento narcisistico di beni superflui si verifichi una sottile ed effimera fusione narcisistica dell’Io con se stesso. Come sosteneva già Stirner la dimensione singolare e narcisistica del capriccio è – in effetti – proprio ciò che definisce la mia unicità. Bisogna stare molto attenti qui a non banalizzare la profondità del concetto neo-liberale di libertà, esso infatti non può essere bollato semplicemente come sciocco, ignorante o narcisistico in senso ingenuo: in esso si annida una questione politica cruciale, che purtroppo è ancora ben lontana dall’essere risolta. Concentrare l’analisi economica e politica sul singolo individuo, considerandolo nella sua irripetibile unicità e nel suo insondabile capriccio, ha rappresentato storicamente una coraggiosa presa di distanza sociosimbolica dalle maschere della società. Una critica banalmente moralistica e paternalistica di questa esperienza, che è il cuore pulsante del consumo capitalista (e quindi del suo stesso modo di produzione), è destinata in partenza a mancare eternamente quello che vorrebbe essere il proprio reale bersaglio.
Nei Manoscritti Marx coglie proprio il dato “culturale”, e in qualche modo “psicologico”, che permette alla proprietà privata e al consumo di agganciarsi a quelli che sembrerebbero essere i “naturali” desideri coscienti dei soggetti delle società capitaliste. La singolarità e l’individuazione si realizzano e si costruiscono – nella società capitalista – attraverso il godimento narcisistico e progettuale della proprietà. La critica morale di questo godimento “mortifero” è già stata molto ben condotta da Massimo Recalcati. La psicanalisi oggi più in voga però, nella sua crociata morale contro questo godimento edonistico, narcisistico, individualizzante e al contempo segretamente nichilistico, sembra aver completamente rimosso l’esistenza di una terza via.
Se abbiamo infatti detto finora che esiste una linea contro-umanista che si ispira variamente a Marx nella storia del pensiero e della cultura del Novecento, potrebbe forse essere necessario oggi mettere a tema anche un contro-godimento (che il lacanismo “ortodosso” contemporaneo sembra voler inspiegabilmente rimuovere). Questo tipo di godimento alternativo, che a me interessa particolarmente, e che è tematizzato nelle pagine più tormentate del tardo Lacan (quelle in cui non a caso lo psicanalista francese non può fare a meno di confrontarsi con Marx) è un godimento che, pur restando qualcosa di essenzialmente egoistico (quindi tutt’altro che moralizzante o paternalistico), non ha a che fare con il consumo di beni o con il raggiungimento di obiettivi. Il più-di-godere, che Lacan associa al plus-valore marxiano, è un passaggio dal singolare all’impersonale. Attenzione però, questo passaggio all’anonimo, o all’acefalo, non è il tradizionale passaggio – classicamente suffragato dalla doxa marxista – dal singolare al comune (un passaggio che in realtà mantiene segretamente intatto proprio quel soggetto-della-coscienza su cui si regge l’intero edificio capitalista). Lo scarto tra il singolare godimento narcisistico di beni e l’impersonale godimento lacaniano, si produce piuttosto proprio nell’esperienza della destituzione del soggetto che pensa di desiderare. Questa dimensione ulteriore, supplementare e non antitetica, del godimento rappresenta un’esperienza soggettiva che non deve essere in alcun modo considerata più originaria, né più naturale, rispetto a quella della seconda natura capitalista. Questo godimento altro è piuttosto un’alternativa positiva, storica, affermativa, al regime capitalista di soddisfazione individuale. È un modo alternativo di valorizzare l’intrinseca macchinicità dell’uomo. Questo passaggio è un passaggio politico cruciale che chiama in causa ogni soggetto a livello della propria vita privata e dei propri rapporti personali. Credo che l’esperienza di questo rovesciamento dell’economia della soddisfazione soggettiva sia davvero in grado di produrre importanti ricadute etico-pratiche, tanto a livello dei rapporti intersoggettivi tra individui, quanto a livello degli stessi rapporti di produzione. Si tratta in fondo del passaggio da un’idea di Uomo ancora ancorata alla coscienza, ad un’esperienza dell’umano sganciata dal tradizionale riferimento primo alla coscienza.
Muni: La differenza che salta maggiormente all’occhio tra i due tipi di godimento che lei ha menzionato mi sembra risieda nel fatto che mentre nel primo caso, quello edonistico, il godimento sembra connesso sempre ad un acquisto crescente di oggetti e di beni, nell’altro tipo di godimento l’oggetto del godimento sembrerebbe coincidere paradossalmente con una perdita. Una perdita nient’affatto vaga o indefinita, ciò che si tratterebbe di perdere parrebbe essere proprio il riferimento privilegiato alla coscienza nella propria personale, egoistica e sacrosanta rincorsa alla soddisfazione individuale. Tutto questo suonerà senz’altro a molti come qualcosa di assurdo… Qualcuno infatti, a questo punto, potrebbe ribattere: “Ma come faccio a soddisfarmi, se non so prima cosa mi piace?” Oppure, “Che cosa dovrei ascoltare, se non i miei pensieri, quando voglio capire che cosa desidero?”
Ronchi: Anche se può sembrare surreale, e senza dubbio spaesante, secondo questo discorso la coscienza e l’Io sono da sempre già presi nell’ingranaggio della macchina capitalista, ne sono l’effetto. Il godimento ulteriore di cui parla Lacan è un godimento che si manifesta proprio negli intoppi e negli apparenti fallimenti quotidiani degli individui rispetto alle loro coscienti aspirazioni. L’insoddisfazione e il senso di miseria sono sentimenti generati strutturalmente dal sistema capitalista; non è un caso che la soddisfazione individuale nel sistema capitalistico sia indicizzata alle aspirazioni “coscienti” – e irrealizzabili – prodotte macchinalmente dal dispositivo. Il capitalismo sussiste solo generando miseria e mancanza attraverso l’effimera e frustrante soddisfazione di desideri indotti, capricciosi e superficiali.
Il godimento ulteriore articolato da Lacan coincide paradossalmente proprio con questo momento di massimo dispiacere e frustrazione; il godimento lacaniano si presenta proprio nel momento in cui non riesci più a funzionare come sano e normale ingranaggio della macchina, divenendo impercettibile, impalpabile, inutilizzabile. Si produce, ad esempio, quando il tuo consumo (e la tua vita) smettono gioiosamente di seguire le regole razionali del capitale, oppure quando – in quanto macchina umana – godi del fatto stesso di essere macchina e non di quello che è il tuo prodotto.
Non bisogna aver paura di chiamare questo godimento col suo nome: pulsione di morte. In questa chiave etica e politica però, la pulsione di morte perde il suo lugubre aspetto di pura cupio dissolvi, indicandoci piuttosto una possibilità operativa, e gioiosa, di sottrazione politica (e di complicità intersoggettiva).
Nel suo bellissimo saggio su Sacher-Masoch (Il freddo e il crudele) Deleuze – sulla scia di Lacan – si cimenta in una lettura della pulsione di morte radicalmente alternativa (e positiva) rispetto a quella tradizionale, affermando che la pulsione di morte – e il particolare tipo di godimento che l’accompagna – si incontrano letteralmente in un al di là del principio del piacere. Il godimento sarebbe così al contempo un al di là e un al di qua del desiderio. Nel godimento il soggetto del desiderio, della mancanza e della coscienza è sospeso insieme all’esperienza intersoggettiva di stampo fenomenologico.
Muni: È come se, a partire dall’esperienza di perdita di quello che abitualmente definiamo “me stesso” (cioè il nostro io coscientemente desiderante), potessero prodursi paradossalmente una soddisfazione e una salute rovesciate… È questo che intende?
Ronchi: Sì! E no. Sì, ma solo se siamo davvero in grado di superare i concetti di mancanza e finitezza che sono a fondamento dell’uomo capitalista e che provengono perversamente dalla lunga tradizione esistenzialista. Tutto il Novecento si è sviluppato lungo questa premessa, assunta come assolutamente ovvia, di una mancanza originaria. Quando dico che la finitezza è stata assunta come fondamento, intendo dire che l’Uomo (identificato al soggetto trascendentale) si è esperito come strutturalmente mancante, cioè come il portatore di una mancanza che ha cercato di colmare attraverso la conoscenza, aggirando così la propria mancanza a essere costitutiva, cioè il fatto storico e politico che il soggetto trascendentale non è che un prodotto storico-culturale. Ecco in che modo l’esperienza lacaniana del godimento si articola con l’esperienza di una perdita, una perdita che non produce una mancanza, ma che piuttosto permette di fuoriuscire da un’esperienza soggettiva fondata sul triste e insoddisfacente pilastro della mancanza.
L’Uomo del Novecento, concepitosi come mancante, ha fatto della mancanza il cuore dell’esperienza. Ma come non accorgersi che, se facciamo della mancanza il cuore dell’esperienza (e su questo sono tutti d’accordo), ci mettiamo a giocare esattamente lo stesso gioco del discorso del capitalista – che ci vuole mancanti per asservire i nostri desideri coscienti al sistema produzione-consumo?
È davvero così casuale la coincidenza tra il formidabile processo di autovalorizzazione del capitale e questa fede incondizionata nella coscienza-della-mancanza come fondamento dell’esperienza?
Il capitalismo avrebbe potuto conquistare così violentemente e rapidamente tutto il mondo se a livello culturale non fosse già esistito, in Occidente, un incessante e ridondante riferimento alla mancanza come dimensione originaria? Torniamo ai Manoscritti e al Capitale: vi si dice chiaramente che il capitalismo produce miseria attraverso la ricchezza, e ricchezza attraverso la miseria. Il sistema capitalistico non può rinunciare a una sola cosa: alla mancanza, al bisogno, all’insoddisfazione, alla frustrazione. Il sistema capitalistico non può strutturalmente produrre alcuna reale duratura soddisfazione, se lo facesse semplicemente si autodistruggerebbe.
Se desiderio è mancanza, il godimento, che è il suo aldilà, potrebbe essere considerato come una paradossale identità di vuoto e pienezza connessa ad una speciale perdita. Allora, per andare al sodo, e per pensare politicamente la cultura e la filosofia, credo si possa dire che in un certo senso, seppur in buona fede, tutto il discorso ingenuo sulla mancanza come fondamento dell’esperienza soggettiva si è reso finora complice, certamente in buona fede, del sistema capitalistico stesso.
Muni: Dunque quello che in un suo bel saggio lei chiama il “reale del capitalismo” sarebbe proprio questa produzione massificata di mancanza e frustrazione, attraverso cui si genera strutturalmente la pulsione stessa al consumo superfluo e all’arricchimento?
Ronchi: In parte sì. Non si può pensare di contrastare la autovalorizzazione del capitale utilizzando il vocabolario della mancanza, del desiderio e della finitezza, perché questi concetti sono esattamente quelli di cui il capitale si nutre. Possiamo vedere anche nelle pratiche post-coloniali qual è stato storicamente l’impatto culturale dell’Occidente. Esso ha prodotto nel mondo un senso di mancanza, un nuovo ordine di desideri, e in generale un diffuso sentimento di insufficienza. L’operazione culturale e colonizzatrice dell’Occidente è stata quella di produrre l’idea stessa di contingenza, l’idea di mancanza, e con essa il desiderio narcisistico del consumo effimero. Quest’operazione è un’operazione che genera debito in senso lato, economico e soggettivo, come già diceva Nietzsche nella Seconda dissertazione della Genealogia. Si tratta di una fabbricazione di memoria e di mancanza prodotta dall’Occidente. Ecco perché il lessico della mancanza e della memoria è a mio avviso totalmente inadeguato a contrastare la macchina capitalistica: esso è – in un certo senso – il motore culturale stesso di questa macchina. So che questa prospettiva è controcorrente, specialmente se confrontata con le varie apologie del limite che sono molto di moda ultimamente.
Muni: Il discorso sulla mancanza in effetti rischia di generare, e forse ha già generato, quell’aspirazione individuale alla perfezione che è così sintomatica nel mondo capitalista. Quasi come se, esperendosi irrimediabilmente mancanti e insufficienti rispetto alle proprie esorbitanti aspettative di vita, i soggetti tendano sempre più ad assecondare il miraggio nevrotico di un’impossibile saturazione delle proprie ambizioni, spostando l’asticella dei propri desideri sempre un po’ più in là di quello che potrebbero realmente ed effettivamente ottenere – o che hanno già ottenuto. Il concetto di “perfezione”, in questo senso, è sintomaticamente uno dei grandi cancri della nostra cultura e delle nostre relazioni umane; ciò che non è perfetto spesso diviene automaticamente insoddisfacente, sostituibile, sorpassabile, perfettibile.
Ronchi: Sì, a questo punto, per concludere, vorrei porre all’ordine del giorno una parola che a mio avviso è fondamentale: la parola “salute”. La salute può diventare una parola rivoluzionaria, come aveva già intravisto Nietzsche. Se il capitalismo, come abbiamo visto, produce incessantemente malattia e mancanza – e basta sfogliare il DSM o pensare al legame economico tra industria farmaceutica e psichiatria per accorgersene – ciò significa che da tempo è in atto una mobilitazione economica e politica permanente, volta alla produzione di malattia e al sentimento dell’anormalità.
Il mito di una salute (fisica e mentale) perfetta serve a produrre una sensazione di mancanza e di disagio, così come il mito di un’automobile, di una casa, di un lavoro o di un compagno di vita perfetti acutizzano il senso di insoddisfazione verso tutto ciò che di reale incontriamo nella vita.
In opposizione a questa triste spirale, che tutti conosciamo molto bene nelle nostre vite quotidiane, un concetto rivoluzionato di “salute” potrebbe tradursi in un non mancare di.
Risignificata come esperienza soggettiva, e non normativa, l’idea di salute potrebbe rappresentare una via d’uscita importante dalla spirale di automedicalizzazione e autofrustrazione in cui siamo presi; la salute rende imprendibili, non ci sono dispositivi per la salute, ci sono dispositivi solo per i cosiddetti malati, per gli “anormali”. L’ipotesi della salute in questo senso è rivoluzionaria: non è una rivendicazione astratta di una perfezione che di fatto non si ha (e non si potrà mai avere), questa sarebbe già una nevrosi o nel migliore dei casi una forma di malafede. La salute a cui penso, proprio come la grande salute nietzscheana, è piuttosto rapporto con se stessi non viziato in partenza dal presupposto della mancanza. Salute vuol dire saper fare qualcosa di quello che si è, o, parafrasando la celebre frase di Sartre sulla libertà “essere in salute vuol dire saper fare qualcosa di ciò che gli altri hanno fatto di noi”. La salute a cui penso è proprio questa capacità affermativa di fare qualcosa con ciò che si è. In questo senso può esserci salute anche in una situazione di reale malattia fisiologica, ad esempio quando essa si traduce nell’appello ad una morte degna. Persino il suicidio, in certe occasioni, può essere il sintomo di una grande salute. In questo senso la salute diviene un fondamento, soggettivo e relativo, da cui poter ripartire per pensare delle pratiche e delle contropolitiche della soggettività e del godimento. Essere in salute vuol dire farla finita con il finire.
Muni: Questo suo concetto di “salute” potrebbe anche essere un modo di attualizzare e dare corpo alla sovversione politica della soggettività (e del concetto di verità) già inscritta a chiare lettere da Marx nell’Undicesima tesi su Feuerbach? “Finora i filosofi si sono preoccupati di interpretare il mondo, ora bisogna cambiarlo”…
Ronchi: Certamente. Aggiungerei, riguardo alla celeberrima frase di Marx, che essa condensa magnificamente un po’ tutto ciò di cui abbiamo parlato finora. L’interpretazione presuppone infatti che l’uomo sia abitato da una fondamentale mancanza di conoscenza o di verità. L’idea tradizionale di interpretazione condanna il soggetto ad un rapporto frustrante con una verità nascosta, con un eterno enigma che egli deve finalmente conoscere,lasciandosi infine – come premio finale – colmare dalla luce della verità. L’interpretazione, nella sua accezione tradizionale, presuppone in fondo sempre l’esistenza di una verità intesa coma qualcosa di cui il soggetto manca. Nella parola trasformazione invece il soggetto si trova in una dimensione operativa (e intersoggettiva) completamente diversa rispetto alla verità: da un lato (nell’interpretazione) si tratta farsi colmare dalla verità accogliendola e facendole spazio, mentre dall’altro (nella trasformazione) si tratta di creare la verità; non si tratta più quindi di una mancanza che cerca il proprio riempimento, ma di una prassi che si eccede continuamente. L’Undicesima tesi su Feuerbach afferma che il mondo, e l’uomo, possono conquistarsi (e costruire) un’altra verità, creandola a partire da niente.
Muni: La verità dunque, per Marx come per Nietzsche, non è fatta per essere conosciuta…
Ronchi: La verità non è già data, e se non è già data ciò significa che essa è prodotta da noi: si trasforma con noi e attraverso di noi. L’idea di una verità ultima e oggettiva (o universale), che ci sfugge eternamente, non è che il contraltare logico di un’esperienza della soggettività fondata a partire dal concetto di mancanza. In Marx e Nietzsche la verità si crea con l’accadere stesso, storico e politico, degli uomini concreti in relazione. È una verità che nasce con i soggetti che la affermano, e che lavorano insieme per darle corpo e realtà. Questa è una concezione salubre di verità. La verità, per Marx come per Nietzsche, è la prassi stessa: essa coincide col suo accadere, e noi siamo sempre responsabili, globalmente e singolarmente, di questa preziosa libertà che è sempre, al contempo, anche un grande pericolo.

